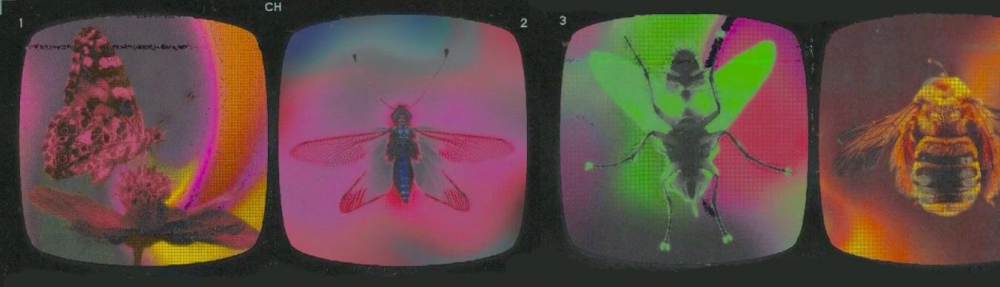Il 29 Maggio abbiamo organizzato il nostro primo cineforum. Di seguito la nostra restituzione della lettura critica che abbiamo proposto.
***
Guerra, bracconaggio e aziende minerarie. Dinnanzi a queste tre grandi minacce che incombono su Virunga, parco nazionale nella provincia del Kivu Nord in Congo, l’omonimo documentario Virunga racconta l’eroismo dei rangers del parco per difendere la riserva naturale e i gorilla di montagna.
Il film ha indubbiamente dei meriti: immagini magnifiche si alternano a testimonianze riprese con telecamere nascoste che rivelano come l’immagine dell’Africa selvaggia e infantilizzata dei colonizzatori europei continui a vivere nella mente dei nuovi poteri coloniali capitalisti a distanza di più di 50 anni dall’indipendenza (il film è del 2014). L’indignazione che genera il razzismo dei dipendenti della compagnia britannica SOCO e la possibilità stessa che quest’ultima possa fare esplorazioni petrolifere in un parco naturale si unisce al senso di urgenza causato dalla presenza di gruppi armati.
Tuttavia, il film lascia nell’ombra alcune questioni mastodontiche preferendo una narrazione “buoni-cattivi” holliwoodiana.
Quello che può sembrare un episodio marginale, all’inizio del film, ovvero il fermo di un bracconiere e l’incendio al suo accampamento è in realtà una finestra su due fenomeni estremamente diffusi in molti paesi africani: il militarismo verde e la marginalizzazione e l’espropriazione delle popolazioni locali.
Il modello di conservazione (occidentale) proposto per i paesi africani (e per l’India, la Thailandia e numerosi altri paesi) si basa sulla conversione delle foreste in parchi nazionali, che porta alla criminalizzazione dei popoli indigeni, ai quali non sono più consentite attività di caccia, raccolta e agricoltura all’interno del parco. Queste persone, di colpo, acquisiscono l’etichetta di “bracconiere”.
Come racconta l’organizzazione internazionale per i diritti dei popoli indigeni Survival in tantissime delle sue inchieste, le attività di sussistenza e il bracconaggio commerciale sono combattute come se fossero lo stesso fenomeno, la cui unica soluzione risiede nell’armare pesantemente i rangers.
È questa una strategia ampiamente adottata in Africa, la cui esistenza è arrivata clamorosamente sotto gli occhi occidentali quando nel 2016 la stessa Survival accusò presso l’OECD il WWF di violazione dei diritti umani. Le squadre antibracconaggio sostenute e finanziate dal WWF avrebbero infatti perpetrato pestaggi e torture ai danni dei popoli tribali Baka in Camerun.
In merito a Virunga, il giornalista congolese Eric Mwamba ha descritto i rangers come “mitragliatrici nella nebbia”, mentre la ricercatrice olandese Esther Marijnen, nei suoi studi sul parco, riporta come per chi vive nei pressi, i rangers non siano eroi ma l’ennesimo gruppo armato che minaccia la sopravvivenza della popolazione. Accampamenti devastati, utensili e reti da pesca distrutti, arresti e percosse sono i frutti, poco cinematografici, che la popolazione locale raccoglie dalla convivenza con i rangers.
Alla luce di queste considerazioni non si può non notare come nel film vi sia la totale assenza del punto di vista della popolazione locale civile. I rangers del parco Rodrigue e André, il principe belga e direttore del parco Emmanuel de Merode e la giornalista francese Mélanie Gouby sono le uniche voci narranti.
L’invisibilità della popolazione civile avviene tuttavia su più fronti. Come documenta Esther Marijnen, il film nel 2015 poteva essere visto in più di 50 paesi e il Congo non era tra questi. La pagina Facebook del parco, che ricordiamo essere situato in un paese che parla francese, kikongo, lingala, swahili e tshiluba è in inglese e fino al 2015 anche il sito era unicamente in lingua inglese. Riassumendo con le parole dello scienziato congolese Paul Katembo Vikanza il parco sarebbe stato creato dal muzungu (bianco) per il muzungu.
Inoltre, la spettacolarizzazione della violenza e la romanticizzazione della figura dei rangers sono vantaggiose a fini economici. Il film si apre con il funerale di un ranger e si conclude con l’invito ad unirsi alla lotta per Virunga. A chi approda sul sito del parco nazionale, nella sezione delle donazioni, si chiede di non rendere vano il sacrificio dei rangers: con 35$ si supporta un ranger per un giorno, con 50$ si supportano la vedova e i figli di un ranger caduto e, solo come terza opzione, con 150$ si supporta un gorilla per due settimane. Degno di nota è il fatto che tra le opzioni di donazione non vengano menzionati contributi per programmi di supporto alla popolazione locale che renderebbero sicuramente meno gravoso e pericoloso il lavoro dei rangers.
Non è dato sapere se l’uomo ritratto all’inizio del film fosse un cacciatore di sussistenza o un trafficante commerciale (anche se la presenza di una pentola e le successive dichiarazioni dei rangers sul fatto che la maggior parte del bracconaggio è “tradizionale” potrebbero far propendere per la prima opzione). Di sicuro però bisogna riflettere sul fatto che la caccia di sussistenza e il bracconaggio non differiscono nella sostanza, ma solo nella forma. Il cacciatore diventa bracconiere da un giorno all’altro se una foresta improvvisamente acquisisce uno stato speciale. Un fatto che diventa paradossale se si pensa che, se da un lato si si negano attività di sussistenza nei parchi naturali, dall’altro lato molti paesi africani (Sud Africa, Botswana, Namibia, ecc.) consentono la caccia, riservandola a ricchissimi bianchi occidentali, di quei mammiferi che sono protetti. Questi cacciatori non sono bracconieri, ma vengono nobilitati come “sportivi”. La moralità della caccia sportiva è inoltre riconosciuta in quanto i cacciatori, con le loro quote economiche per cacciare, contribuiscono al benessere economico delle istituzioni che organizzano queste forme di turismo e, paradossalmente, si sostiene che partecipino di conseguenza al benessere generale di tutti gli altri animali non ammazzati che beneficiano quindi di maggiori cure, grazie alla maggiore disponibilità economica.
Se non è dato sapere chi fosse l’uomo ritratto all’inizio del film e se comunque la divisione buoni-cattivi del film ignora volutamente le difficoltà che la popolazione congolese ha affrontato senza interruzioni dalla colonizzazione alla guerra civile, passando per una delle dittature peggiori della storia africana, è invece innegabile come la lotta armata al bracconaggio cerchi di rispondere al fenomeno immediato senza andare a colpire le cause più profonde per le quali esso avviene.
Il dubbio è che ciò che avviene a Virunga, così come gran parte delle strategie conservazioniste moderne, sia il prodotto di un razzismo ecologista. La domanda di prodotti esotici (avorio, corna di rinoceronte, carne di gorilla), che avviene soprattutto in paesi extra-africani ed è alla radice dell’estinzione di tante specie, è combattuta globalmente e politicamente con la stessa aggressività con la quale si fronteggia la lotta al bracconaggio in Africa? L’aumento del bracconaggio, del resto, è sicuramente più correlato all’aumento della ricchezza in Asia piuttosto che ad altri fattori sociali in Africa. Inoltre, secondo il CITES, l’Italia è il terzo paese esportatore di avorio legale (sic!), ma non vi è nessuna criminalizzazione del “libero commercio italiano” (e un ex diplomatico italiano è stato arrestato ad Aprile in Uganda per il possesso di 5 kg i avorio).
Virunga e gli altri parchi nazionali africani dove vigono policies di sparare a vista ai bracconieri e dove si sceglie consapevolmente di minare la sussistenza della popolazione locale per proteggere gli abitanti non umani che vi abitano sono rari teatri globali in cui la vita non umana viene anteposta a quella umana.
Da antispecistɜ, non troviamo problematico che si riconosca il diritto di un gorilla a vivere nella natura senza essere minacciato. Tuttavia, ciò che invece è problematico è che, in un mondo specista, la vita di un gorilla valga più di quella di un essere umano se, e solo se, l’essere umano in questione sia nero.
Il razzismo ecologista si fonderebbe quindi sull’idea che l’Africa (o in altri casi i paesi orientali) sia una terra selvaggia, la terra della natura. La protezione degli animali che vi abitano sarebbe motivata da questi sentimenti uniti ad un gusto per l’esotico. Una tesi, questa, che sembra avvalorata dal fatto che in occidente, quando gli interessi della natura confliggono con quelli della popolazione, è sempre la prima a soccombere e la recente storia degli orsi del Casteller – orsi che sono stati ingabbiati per incidenti di lievissima entità – confermerebbe questa teoria.
Trasponendo infine il militarismo verde al futuro più immediato, all’orizzonte vi è la COP15 che si terrà a Kunming, in Cina, ad ottobre. La proposta che avanzano molti governi occidentali è di proteggere il 30% delle aree del pianeta entro il 2030: un intento nobile se la protezione non implicasse i modelli di conservazioni neocoloniali già illustrati in precedenza. Inoltre, va di nuovo fatto notare, la crisi climatica e la perdita di diversità non avvengono a causa di mancanza di protezione di alcune aree, ma a causa di precisi modelli economici che una proposta come quella del “30% entro il 2030” ignora volutamente.
Fonti:
– E Marijnen, J Verweijen, Selling green militarization: the discursive (re) production of militarized conservation in the Virunga National Park, Democratic Republic of the Congo
– R Duffy, F Massé, E Smidt, E Marijnen, B Büscher, J Verweijen, Why we must question the militarisation of conservation
– J Verweijen, E Marijnen, The counterinsurgency/conservation nexus: guerrilla livelihoods and the dynamics of conflict and violence in the Virunga National Park, Democratic Republic of the Congo
– E Marijnen, Public authority and conservation in areas of armed conflict: Virunga National Park as a ‘state within a state’in eastern Congo
– ME Baaz, D Gondola, E Marijnen, Virunga’s White Saviour Complex: How the Film Distorts the Politics and People of Congo
– Eric Mwamba, Machineguns in the mist
– Il sito dell’ONG Survival per informazioni generali e globali sul militarismo verde
 Proiezione del documentario “Il mio amico in fondo al mare” e dibattito
Proiezione del documentario “Il mio amico in fondo al mare” e dibattito