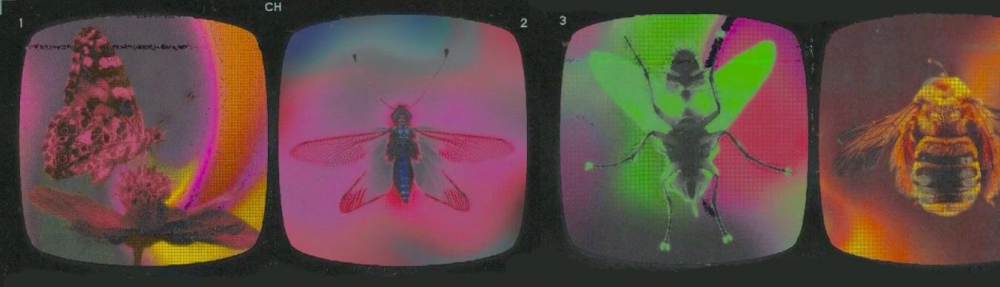Il 19 Giugno, in occasione del nostro secondo cineforum, abbiamo proiettato Deforestazione made in Italy, un documentario che porta avanti la tesi che gli allevamenti del futuro siano quelli del passato. Gli interessi degli animali non umani, come al solito, sono invisibili. Di seguito proponiamo la nostra riflessione su un film che, pur essendo ricco di informazioni, possiamo definire un capolavoro di bioviolenza.
***
Tra i lupi mannari e gli unicorni delle storie popolari, tra gli gnomi e le fate delle leggende, l’immaginario folkloristico italiano è abitato da tantissimi miti e leggende. Nessuno però è più radicato nella nostra cultura del mito degli “italiani brava gente”.
Si tratta di un’autorappresentazione falsa (e nazionalista) così cristallizzata nella cultura italiana che ormai non è più esclusiva della storia coloniale in cui è nata, ma assume declinazioni diverse a seconda dell’occasione.
Gli “italiani brava gente” in tempi di guerra erano soldati miti, bonari, tolleranti, gioviali, incapaci di atti crudeli. È un mito che ha resistito agli attacchi della storiografia, che ha documentato come i nostri connazionali fossero invece colonizzatori efferati come tutti gli altri, con le loro armi chimiche e le loro pratiche di madamato.
Dinnanzi ai cambiamenti climatici, il mito degli “italiani brava gente” ritorna. Non è possibile immaginare che anche gli italiani, con la loro cucina, siano responsabili di danni al pianeta. Noi siamo la terra della dieta mediterranea, della pizza, della bresaola, del formaggio. Sembrerebbe impossibile che le eccellenze gastronomiche italiane possano contribuire alla deforestazione. Non sarà forse tutta colpa dellә altrә, degli hamburger americani o delle abitudini culinarie cinesi?
Il documentario Deforestazione made in Italy sembra voler scalfire questo mito collettivo nazionale andando a colpire l’Italia nell’orgoglio: il made in Italy distrugge le foreste tanto quanto i prodotti delle altre economie. Quella dell’autore, tuttavia, è una critica solo parziale. Si colpisce l’Italia nella sua fierezza culinaria per darle la possibilità di rialzarsi, di dimostrare al mondo che la nostra cucina può riabilitarsi ed essere sostenibile senza alterazioni di contenuto.
Si descrive, infatti, un’Italia che vive il paradosso di una grandezza gastronomica legata alla tradizione, al territorio e che può guarire dall’ipocrisia ritornando a una dimensione bucolica, con prodotti locali e a kilometro zero, dove gli allevamenti siano felici ed estensivi e dove la carne sia un prodotto di qualità e non “in quantità”.
È questo un messaggio coerente con tutta l’impostazione del film: gli animali non umani vittime degli allevamenti sono presenti nel documentario, ma come referenti assenti. Sono degli oggetti passivi e inanimati, il cui dramma rimane invisibile per tutta la durata del film.
È in questa assenza che si consuma la rottura tra il movimento antispecista e il movimento ecologista. Se entrambi si intersecano nella loro critica ai modelli di produzione, il secondo non riconosce agli animali non umani lo status di soggetti, ma, tuttalpiù, sono un aggregato variopinto riconducibile alla definizione di biodiversità.
Proprio a questo bivio nasce la bioviolenza, una narrazione nata per rispondere alle criticità etiche ed ecologiche del consumo di carne: una violenza “bio”, green, umana che racconta di una carne felice, di bovini al pascolo, di polli ruspanti, tutto “come una volta”.
Questo ritorno al passato ha però delle note stonate: in epoche preindustriali, gli allevatori avevano con gli animali non umani un rapporto diretto, che era comunque un rapporto di sottomissione e violenza; gli allevamenti intensivi hanno disabituato il consumatore alla violenza sugli animali, allontanando i mattatoi e gli allevamenti, ma allo stesso tempo hanno esacerbato il rapporto di violenza trasformando gli animali in macchine da produzione. Queste due condizioni – la non familiarità con la violenza e il fatto che essa stessa fosse diventata estremamente brutale – hanno fatto mettere in dubbio la moralità del trattamento riservato agli animali allevati. È per coprire questa crepa nel muro dello sfruttamento che si è proposto un ritorno al passato dove il rapporto con gli animali non umani viene edulcorato con la retorica del benessere animale.
Per certi versi, siamo di fronte a “una toppa peggiore del buco”.
Se si riconoscono gli animali come soggetti che non devono soffrire, com’è possibile accettare che possano invece essere uccisi?
Se, come sostiene Jared Piazza, mangiare carne è giustificato dalle 4N, ovvero dalla credenza che mangiare carne sia natural, normal, necessary e nice (naturale, normale, necessario e buono), come si può difendere un sistema di allevamento che renderebbe un alimento “necessario” un prodotto di nicchia, il cui sovrapprezzo escluderebbe fasce della popolazione meno abbienti o che, se volesse includere una fascia maggiore della popolazione, richiederebbe porzioni di terra tali da renderlo immediatamente insostenibile?
Non sono queste, tuttavia, le uniche criticità alla carne felice e sostenibile. Alla bioviolenza della prima ora, fatta di campagne bucoliche e richiami pastorali, ne è seguita poco dopo un’altra “2.0” che ha scatenato nuove forme di accumulazione e ha talvolta rinnegato il passato idilliaco per immaginare un futuro di animali tecnologici con corpi da piegare alle esigenze climatiche o (pseudo)etiche.
Questa bioviolenza 2.0 assume diverse forme. Da un lato si assiste alla creazione di nuovi mercati e nuovi prodotti: il latte di cammella, per esempio, potrebbe essere il latte dei cambiamenti climatici in quanto prodotto da un animale in grado di resistere alla siccità e a condizioni climatiche avverse. L’80% dei cammelli mondiali si trovano in Somalia, Kenya ed Etiopia, quindi possiamo anche immaginare uno scenario geopolitico in cui l’Africa rimane nel suo ruolo di esportatrice di materie prime e produttrice di cibo.
La bioviolenza però non apre le porte solo a nuovi prodotti, ma a nuove forme di accumulazione capitalistica, impensabili poco tempo fa. Ad Aprile 2021, dopo la commercializzazione avvenuta due anni di un integratore alimentare per bovini – il Mootral – che avrebbe ridotto le loro emissioni, sono stati lanciati sul mercato i crediti di carbonio provenienti dalla riduzione delle emissioni di metano enterico di questi animali. In altre parole, i rutti (evitati) delle mucche potranno essere acquistati per ridurre le proprie emissioni (o da grandi aziende), allo stesso modo in cui da anni acquistando un fornello solare per una comunità in Uganda o piantando un albero in Mozambico si può diventare “carbon neutral”.
Nasce quindi una doppia opportunità di guadagno per gli allevatori: non più soltanto i corpi degli animali, ma anche la vendita di crediti di carbonio.
Un’altra opportunità di guadagno proviene dal biogas: negli Stati Uniti stanno prendendo piede costosissimi impianti di digestione anaerobica di liquami e letami prodotti dai bovini che vengono trasformati in biogas per il trasporto o per fornire elettricità. Sono impianti che costano milioni di euro, finanziati soprattutto con soldi pubblici, che vengono raccontati con parole green quali “valorizzazione del refluo zootecnico” o sono narrati come il contributo degli allevamenti alla lotta contro i cambiamenti climatici.
Il paradosso è enorme: viene venduta come energia pulita un’energia che di fatto pulita non è, in quanto, tolto l’impatto del letame, gli altri fattori climalteranti legati agli allevamenti rimangono immutati.
Infine, per concludere la rassegna sui nuovi mercati legati al metano prodotto (o non prodotto) dalle mucche, cinque anni fa l’Istituto Nazionale di Tecnologia Agricola di Buenos Aires ha trasformato le mucche stesse in fonti di biocarburante. Collegando un sistema di tubi all’interno dello stomaco della mucca con un sacchetto fissato sulla schiena, è possibile raccogliere il metano prodotto dall’animale nel corso della giornata. Una volta estratto, il gas viene depurato e inserito in bombole che ne permettono la fruizione.
Questo zainetto non è di certo l’unico accessorio invasivo inventato per ridurre le emissioni. La pandemia deve probabilmente aver ispirato quegli scienziati che hanno pensato di creare delle mascherine per le mucche che intrappolano il metano prodotto attraverso rutti.
L’unico limite della bioviolenza è la fantasia. Non si creano solo tante nuove forme di accumulazione e mercificazione quante è possibile pensarne, ma, addirittura, si progettano animali affinché soddisfino particolari requisiti etici: mucche senza corna affinché non debbano essere sottoposte alla procedura dolorosa di decornazione (pratica eseguita per prevenire i danni che queste potrebbero provocare alle loro compagne di sventura negli spazi angusti degli allevamenti intensivi e soprattutto per disarmarle del loro unico strumento di difesa contro gli allevatori); maiali con testicoli che non si sviluppano per evitare che questi debbano essere castrati senza anestesia (pratica eseguita perché i maiali castrati hanno una carne qualitativamente superiore per il mercato); infine, ritorna ciclicamente l’idea di causare una disabilità agli animali per migliorare il loro benessere, come per esempio creare galline cieche affinché, sotto stress, becchino meno efficacemente le loro compagne (il cannibalismo è una questione ordinaria negli allevamenti intensivi) o, addirittura, animali incapaci di soffrire per risolvere rapidamente la questione se sia etico fare del male ad un animale in grado di provare dolore.
Anche da un punto di vista ambientale, l’unico limite della bioviolenza è l’immaginazione: polli senza piume affinché si possa risparmiare acqua nell’operazione di spiumaggio; mucche con particolari capacità di termoregolazione corporea affinché non patiscano gli stress climatici; mucche nane che con le loro ridotte dimensioni si adattino a contesti di autoproduzione e, soprattutto, consumino meno risorse in confronto alle loro sorelle più grandi, producendo proporzionalmente più latte e carne.
Semplificando, ci sono due tipi di strategie: da un lato la bioviolenza bucolica, quella del prodotto di nicchia, che guarda al passato, che si rivolge al consumatore medio-alto in grado di pagare un prezzo premium; dall’altro la bioviolenza 2.0, quella che guarda al futuro e che con sincero cinismo ammette che le gabbie più grandi e i pascoli verdi non sono competitivi commercialmente su larga scala e che un intervento diretto sulla genetica permetterebbe di ottimizzare i costi e i profitti rendendo contentә ecologistә e pseudoanimalistә.
Non spenderemo ulteriori parole per evidenziare il paradosso di cercare di garantire il benessere di un animale che si riconosce in grado di soffrire, ma che si sceglie di far morire prematuramente.
Vogliamo lanciare in quest’occasione, invece, un’ultima riflessione sulla bioviolenza ecologista. Il ritorno agli allevamenti “come una volta”, la manipolazione di corpi animali per renderli adatti ai cambiamenti climatici, la trasformazione di mucche in fonti di energia renderanno il pianeta più green?
La risposta dipende da quale progetto si vuole realizzare.
La bioviolenza è infatti solo uno dei tanti vestiti nuovi dell’imperatore capitalista. Sono stati cuciti dagli stessi abili sarti dell’economia neoliberale che hanno tessuto le lodi della green economy quando ormai era evidente che il nostro modello di sviluppo era devastante. Il meccanismo è sempre lo stesso: il gattopardiano “se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”.
La bioviolenza è questo: grandi cambiamenti per mantenere intaccati il profitto e i rapporti di dominio sugli animali, così come la “green economy” e lo “sviluppo sostenibile” sono rivoluzioni di facciata (passive, direbbe Gramsci) per mantenere saldi la speculazione sulla natura e i rapporti di gerarchia con paesi extra-europei, (Africa Sub-Sahariana, in primis).
Pensiamo che il movimento ecologista e quello antispecista debbano incontrarsi sull’asse della lotta al capitalismo, l’ideologia responsabile della crisi climatica.
Per noi non è immaginabile una fine del capitalismo senza che sia demolita anche l’idea dell’umano “figlio di Dio”, signore e padrone del mondo, senza che venga superata la separazione dell’essere umano dagli altri esseri viventi, senza che sia messo a tacere per sempre il delirio umano di onnipotenza.
La costruzione di gerarchie inter-specie e intra-specie è fondamentale per la riproduzione del capitalismo e, conseguentemente, è una causa fondamentale della crisi climatica. Un movimento ecologista che ignori le istanze antispeciste e che rimanga arenato in una nostalgia verso il passato non rischia solo di essere miope, ma rischia soprattutto di essere totalmente vuoto.
Fonti:
Marco Maurizi, 2011, Antispecismo, allevamento “tradizionale” e auto-produzione,
http://bioviolenza.blogspot.com/2011/03/antispecismo-allevamento-tradizionale-e.html
Jared Piazza, 2015, Rationalizing meat consumption. The 4Ns, https://www.researchgate.net/publication/274901470_Rationalizing_meat_consumption_The_4Ns
Raisa Scriabine, Dairy Alternatives: Rethinking Milk In California and Kenya
Elisa Valenti, 2019, Senza piume, senza corna, senza senso, http://bioviolenza.blogspot.com/2019/06/senza-piume-senza-corna-senza-senso-le.html
Cow burps are being used to offset our carbon emissions, www.euronews.com/green/2021/04/22/cow-burps-are-being-used-to-offset-our-carbon-emissions
Cargill Backs Cow Masks to Trap Methane Burps
www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-01/wearable-technology-to-filter-cow-methane-burps